News e Comunicati stampa
Tumore alla prostata: nell’organizzazione del DNA potrebbe esserci una chiave per distinguere i casi a basso e alto rischio
2025.10.22
Grazie a un approccio interdisciplinare innovativo, un gruppo di ricercatrici e ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) e dell'Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC (IFOM) ha identificato nell'analisi dell'organizzazione del DNA una chiave che potrebbe permettere di distinguere i casi di tumore alla prostata a basso rischio da quelli ad alto rischio. I risultati, se saranno ulteriormente validati in studi preclinici e clinici, potrebbero aiutare a guidare decisioni per terapie più precise e mirate.
I dati, appena pubblicati sull'autorevole rivista scientifica Nature Communications, sono stati raccolti in una ricerca condotta grazie al sostegno decisivo di Fondazione AIRC e alla collaborazione clinica dell'Ospedale IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Milano, 22 ottobre 2025 - Il tumore della prostata rappresenta la seconda neoplasia più comune tra gli uomini a livello mondiale e la più diffusa nei Paesi occidentali, con oltre 1,4 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno secondo i dati del Global Cancer Observatory. Nell’Unione Europea questa patologia colpisce circa 450.000 uomini all'anno, mentre in Italia si registrano oltre 36.000 nuovi casi annualmente, soprattutto sopra i 65 anni d’età.
In aggiunta alla sua elevata incidenza, il tumore prostatico presenta una sfida complessa per la valutazione del rischio. Se infatti la maggior parte dei casi si manifesta in forma indolente e a crescita lenta, circa il 20% evolve verso forme metastatiche e letali, e distinguere tra le due categorie di pazienti non è facile. L’attuale percorso diagnostico si basa sulla valutazione istologica di biopsie multiple, condotta solitamente a seguito di livelli elevati di PSA o di esami rettali, da parte dello specialista, dall’esito anomalo. Tuttavia la variabilità clinica e la multifocalità del tumore prostatico rendono difficile prevedere con precisione l'evoluzione della malattia, portando spesso al sovra-trattamento di pazienti con forme che col senno di poi si rivelano silenti, con un impatto negativo sulla qualità di vita.
Un gruppo di ricercatrici e ricercatori, sostenuto dalla Fondazione AIRC, ha affrontato questa sfida con un approccio innovativo.
A partire da un’unica biopsia sembra possibile identificare l'organizzazione tridimensionale del DNA nel nucleo cellulare. I risultati dello studio sono da poco pubblicati sulla rivista Nature Communications. La ricerca è stata coordinata da Chiara Lanzuolo e Francesco Ferrari, ed è frutto della collaborazione tra il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'IFOM (Istituto AIRC di Oncologia Molecolare), l'INGM (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) e l’ospedale IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
“La forma della cromatina, ovvero l’architettura del DNA e delle proteine che lo regolano, è da tempo riconosciuta come un indicatore dell’aggressività di diversi tipi di tumore” – spiega Chiara Lanzuolo, ricercatrice del CNR e Direttrice del laboratorio di “Chromatin and Nuclear Architecture” presso l’INGM.
“Noi ci siamo chiesti se alterazioni nell'organizzazione della cromatina dei tumori al momento della diagnosi potessero fornire informazioni prognostiche più accurate rispetto ai metodi tradizionali. Abbiamo inoltre scelto di studiare il tessuto intero per avere informazioni sul microambiente tumorale, che nel caso della prostata ha caratteristiche peculiari perché le cellule neoplasiche crescono in piccole masse disseminate in tutto l’organo”.
Utilizzando la tecnologia innovativa 4f-SAMMY-seq, sviluppata anch'essa nell'ambito di una collaborazione di lungo termine tra gli istituti, i ricercatori, in collaborazione con gli urologi Giancarlo Albo e Manuele Montanari del Policlinico di Milano, hanno analizzato campioni bioptici prelevati alla diagnosi. Il metodo ha rivelato che i campioni di controllo mostrano un'organizzazione conservata della cromatina, mentre i campioni tumorali presentano alterazioni specifiche per ogni paziente.
“Analizzando l'organizzazione della cromatina dei tumori – illustra Francesco Ferrari, Direttore del laboratorio di Genomica Computazionale di IFOM e ricercatore del CNR – sono stati identificati due sottotipi distinti. Uno è caratterizzato da un basso grado di riorganizzazione della cromatina, mentre l'altro mostra un elevato riassetto del genoma. Successivamente, integrando tecniche di biochimica, biologia molecolare e bioinformatica, è emerso un paradosso inaspettato: il sottotipo con alterazioni più estese nell'organizzazione del genoma è associato a una prognosi più favorevole”.
“Abbiamo deciso – prosegue Chiara Lanzuolo – di mettere a confronto i due sottotipi tumorali per identificare una firma molecolare in grado di predire il decorso clinico dei pazienti. La firma individuata consiste di 18 geni e può rappresentare uno strumento concreto per la stratificazione del rischio. Abbiamo validato tale firma con i dati, contenuti in database internazionali e relativi a oltre 900 pazienti, confermando la solidità del nostro approccio”.
“Questo studio – sottolineano Francesco Ferrari e Chiara Lanzuolo – è stato possibile grazie a una collaborazione di lungo corso tra i nostri gruppi di ricerca, e grazie alle sinergie stabilite tra i nostri istituti. Questo ha consentito di costituire un team realmente interdisciplinare di ricercatori che hanno costruito nel tempo i tasselli di conoscenza necessari a raggiungere questo risultato”.
Oltre a distinguere i tumori a basso rischio da quelli aggressivi, i risultati hanno anche evidenziato differenze nell’attività di geni chiave per la crescita tumorale.
“Questi risultati – riflettono Chiara Lanzuolo e Francesco Ferrari – aprono prospettive concrete per la medicina di precisione nel tumore prostatico. Se validata in ulteriori studi preclinici e clinici con i pazienti, la firma molecolare identificata potrebbe essere implementata nella pratica clinica. Potrebbe così aiutare urologi e oncologi a distinguere già alla diagnosi i tumori a basso rischio da quelli destinati a progredire, guidando decisioni terapeutiche sempre più precise e mirate e riducendo il rischio di sovra-trattamento. Le prossime ricerche si concentreranno sui pazienti già sottoposti a trattamenti farmacologici, con l’obiettivo di identificare chi può beneficiare maggiormente delle terapie disponibili e portare, potenzialmente, all'implementazione di questo test diagnostico nella pratica clinica”.
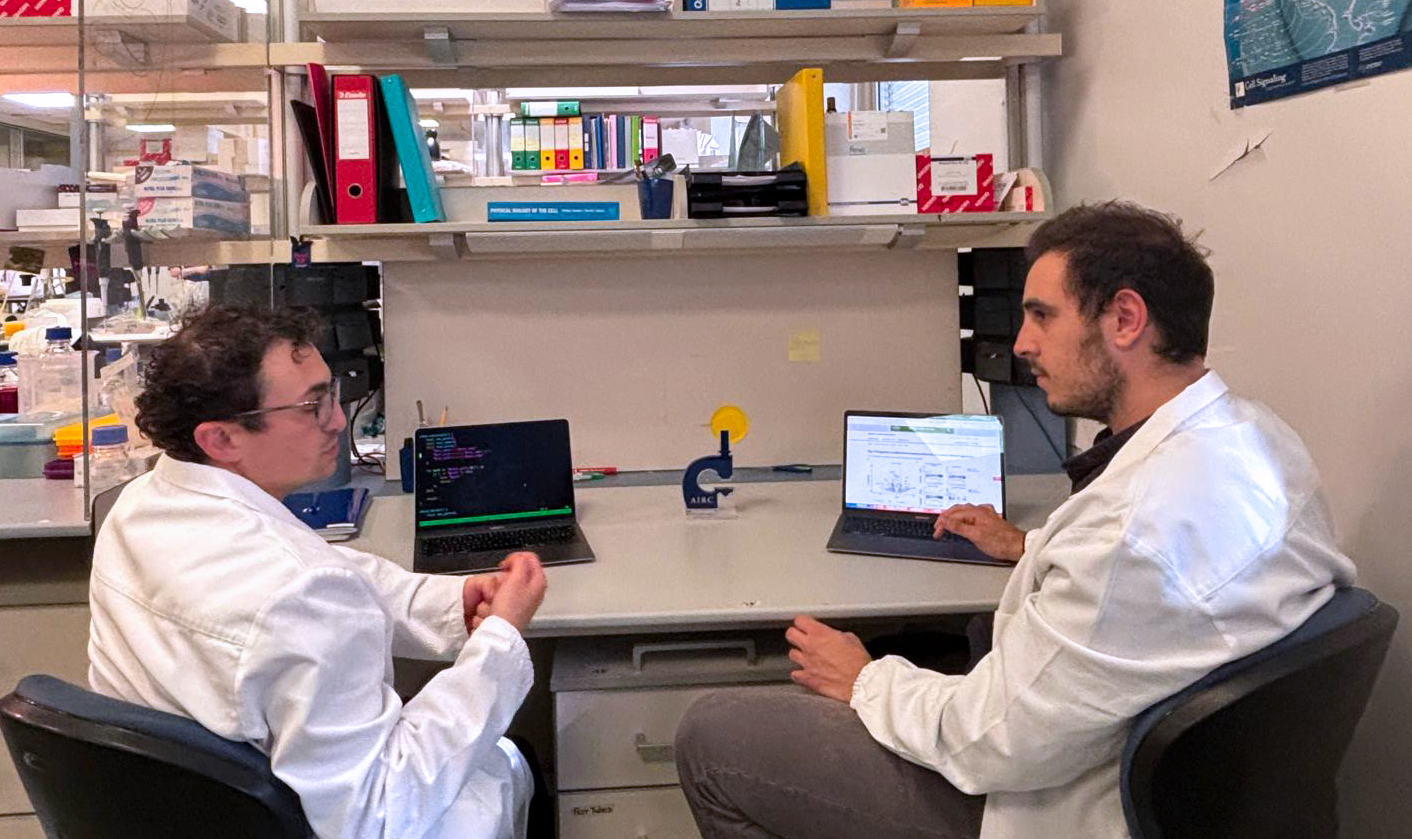
“Ci teniamo – concludono gli scienziati – a ringraziare Fondazione AIRC, senza il cui sostegno non sarebbe stato possibile questo studio, che rappresenta un esempio concreto di come la ricerca italiana possa contribuire al progresso della medicina di precisione. Ringraziamo anche i giovani ricercatori e ricercatrici come Valentina Rosti, Giovanni Lembo e Cristiano Petrini, che hanno avuto un ruolo cruciale nel garantire il successo dello studio”.
“Prendere parte a questa ricerca – afferma Valentina Rosti, borsista del CNR e autrice co-corresponding dell’articolo – è stato per me un vero percorso di crescita: lavorare fianco a fianco con medici e bioinformatici in un progetto così interdisciplinare e contribuire a una ricerca che può avere un impatto concreto sulla vita dei pazienti è stato profondamente motivante”.